In questi giorni sto riflettendo molto sul fenomeno che stiamo vivendo, il COVID-19.
Non che l’Italia negli ultimi anni non abbia ampiamente dispiegato le proprie risorse nell’affrontare momenti di crisi.
Da abruzzese, per esempio, penso a L’Aquila, il 6 Aprile 2009.
In quei momenti ricordo che la mia attenzione e il mio cuore furono catturati profondamente dai racconti circa quegli eroismi anonimi di chi scavava al buio e a mani nude per cercare un vicino di casa, qualcuno di cui forse non si conosceva nemmeno il nome o la squadra preferita o se amasse cucinare.
Nella narrazione che si fa in questi giorni circa il Coronavirus, di tanto in tanto vengono fuori casi di individualismo, ovvero di chi, pensando unicamente al proprio bene, agisce in modo affrettato, senza pensare agli effetti, sconsideratamente.
Mi sono chiesta le ragioni di questo comportamento.
Penso alle attivazioni esplosive della paura, che talvolta diventa panico.
Penso ai tipi di attaccamento, a quello ansioso ambivalente.
Penso altresì a quei genitori che incitano il proprio figlio a compiere un fallo dagli spalti, in un allegro pomeriggio primaverile.
Penso alle occasioni perse quando i prof sostituivano l’ora di Educazione Civica con quella di storia, perché eravamo troppo indietro con il programma.
Penso alla sconsiderata gestione della comunicazione che è stata fatta da Ministri, sanitari, giornalisti, lucratosi dei social, dai divulgatori inconsapevoli.
Penso ai luoghi di educazione: la scuola, lo sport, la musica, il catechismo, il teatro.
Qualcosa nei lunghi anni di tagli a questo settore c’entra con la nostra reazione e il suo continuum, in cui con leggiadria ci si nuove dal polo del “meno di un’influenza” a quello del “devono ridurre la popolazione mondiale perché siamo troppi“.
Ognuno può pensare quello che vuole, per carità.
Ma quei luoghi: la scuola, il campetto, la sala prove, il camerino di un teatro, l’aula del catechismo erano i luoghi in cui s’imparava ad essere comunità.
Mi preme, quindi, sottolineare come sarebbe auspicabile ricreare spazi e momenti in cui sentirsi comunità, ovvero quel luogo fisico, mentale, emotivo, spirituale in cui i fragili hanno attenzione, in cui s’impara che un’azione può avere conseguenze, in cui la libertà è l’altra faccia della protezione, al grido di quel vita tua, vita mea tanto auspicato da Scilligo.
Che c’entra tutto questo con la psicologia?
C’entra nella misura in cui un lavoro nella stanza di terapia, ad esempio, è un gesto psicologico che promuove consapevolezza, cambiamento e benessere, in quanto tale è un gesto etico, poiché è necessario inserire quel benessere personale dentro quello di una famiglia, di una comunità e della società e farci i conti; infine, va da sè, diventa un gesto politico che dal singolo raggiunge tutta la polis, verso un’educazione alla salute, alla bellezza, alla cura, alla tutela, alla partecipazione, alla cultura.


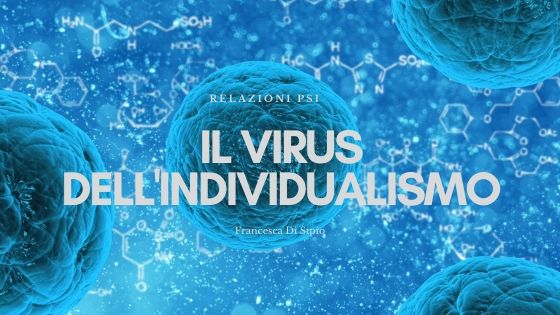











You must be logged in to post a comment Login