Ecco c’è un rischio: quello di schiantarsi contro un concetto, quello di resilienza, che rischia di diventare un mito e di creare dei tabù.
Come società siamo bravissimi a farlo: il mito della taglia 42, che poi è diventata la 38, il mito della donna discreta che lascia spazio all’uomo, il mito dell’uomo che non piange, che non sta a casa con i figli, che deve guadagnare di più della moglie, il mito della moglie che deve guadagnare di meno del marito e stare a casa con i figli, giustificarsi se non ne vuole, il mito in cui il disabile, anzi l’hadicappato andava nascosto… e potrei andare avanti per ore.
Oggi siamo nel mito della resilienza.
La narrazione che spesso ci ha contraddistinti è quella di un ottimismo avulso dalla realtà.
Io non credo agli ottimisti.
Quando si assolutizza un concetto, quando lo si cristallizza, non si fa un buon servizio a se stessi e alla società.
Ed ecco che Berne, fondatore dell’Analisi Trasazionale, con il concetto di controingiunzione ci viene in aiuto.
La controingiunzione è un messaggio piuttosto esplicito e verbale proveniente dai nostri genitori, teso chiederci di risolvere un nostro momento di frustrazione, angoscia, tristezza.
I Goulding ne hanno individuati 5: Sii perfetto!, sii forte!, sforzati! compiaci!, sbrigati!.
Qui mi occuperò del “Sii forte“. Quando le cose vanno male, sii forte! Quando hai voglia di piangere, sii forte! Quando ti senti morire dentro, sii forte!.
Quanto sforzo richiede questo esser forti!
Si tratta di iniziare una lenta svalutazione di se stessi che se reiterata, porta ad uno straniamento, ad un senso di inadeguatezza, a sentirci piccoli e soli infondo a noi stessi.
Significa stringere i denti e passare sopra se stessi, non riconoscere la tristezza, la rabbia, la paura.
La resilienza, come io la intendo, non è un esser forti punto e basta. La resilienza umana è un fatto diverso da quella fisica: una materia è o non è resiliente.
La resilienza umana è un prodotto, nasce dall’incontro di noi con la difficoltà.
La resilienza umana è un processo e non può che nascere dal riconoscimento della nostra fragilità, del nostro limite. Implica l’elaborazione del fatto che non siamo perfetti, che la vita non va come dovrebbe andare, che
spesso la rotta la fa il vento e noi possiamo solo adattare la vela,
che il riconoscimento che quello che capita può essere un’ingiustizia.
La resilienza non è un fatto individuale.
I resilienti che io ho conosciuto sono diventati tali perché avevano qualche mezzo personale e tante risorse nella società.
Ripenso alla storia di Oscar De Pellegrin, campione paraolimpico. Lui ha avuto un amico che, dopo l’incidente per cui ha perso l’uso delle gambe, lo ha spronato e spronato ancora di andare a tirare con l’arco. Lui di sè racconta che era solo a casa a pensare all’incidente.
La resilienza è un fatto pubblico, sociale, che dipende dall’educazione alla fragilità come esperienza che può essere accolta e, non sempre, trasformata.
La resilienza non è un obbligo, può essere una meta auspicabile, ma non può essere un mito.
Siamo fragili, che meraviglia accoglierlo, dirsi e dire “Non ce la faccio, aiutami“, dirsi e dire “Non ce la fai, ti aiuto“.
L’evento Covid, lo dice l’OMS, sta già generando un’emergenza circa i disturbi psichiatrici e il benessere psicologico.
Stiamo dentro una storia di fragilità che va integrata, riconosciuta e accolta.
E allora sii forte, ma se non ce la fai, piangi pure.


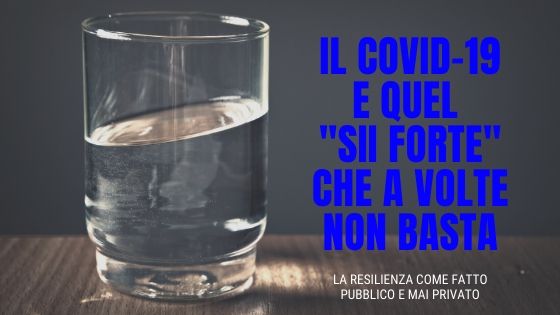











You must be logged in to post a comment Login